
Fiori di creta – di Lucio Zaniboni – Collana letteraria I libri di Cultura Oltre
di Cipriano Gentilino
Fiori di creta di Lucio Zaniboni è un libro che si legge come si ascolta un lungo soliloquio nel cuore della notte, in bilico tra confessione, meditazione e invettiva, tra nostalgia e resistenza, tra il gesto lirico e quello morale. La sua voce non ha nulla di episodico o circoscritto: si estende come un fiume carsico, ritornando di continuo sugli stessi temi — la fragilità dell’umano, la memoria, l’amore perduto, la consapevolezza del limite — senza mai cadere nella ripetizione, ma scavando sempre più a fondo, con stile sobrio, talora visionario, spesso ironico, sempre umano.
Il titolo della raccolta è emblematico: Fiori di creta è un ossimoro che mette in tensione due elementi solo in apparenza incompatibili. Il fiore, simbolo della bellezza effimera, e la creta, materia grezza, modellabile ma destinata a sfaldarsi. Zaniboni parte proprio da questa frattura ontologica per raccontare la precarietà della condizione umana. Ma non c’è rassegnazione nei suoi versi, bensì una lucidità ferita, un bisogno di testimonianza. La poesia, in questa luce, diventa un atto resistente, un graffio sul vetro del tempo, una traccia che cerca — e talvolta riesce — a non dissolversi. Zaniboni scrive come chi ha molto visto, molto vissuto, molto perduto. Il suo sguardo è quello di chi osserva il mondo dall’alto e dal fondo insieme: dal “dodicesimo piano” di un palazzo (“Dal mio studio in abito da clown, / guardo il formicaio che impazzisce”) e dalle viscere della città, dove le sirene della fabbrica e le prostitute si incontrano in un unico, spettrale quadro urbano. C’è qualcosa di pasoliniano nel suo modo di mettere in scena l’umiltà e la miseria del quotidiano: un senso di pietas intrisa di indignazione, e una lingua che sa farsi concreta senza perdere il ritmo lirico. Molti componimenti sembrano frammenti di un diario esistenziale, riflessioni spezzate da epifanie o da aforismi (“È ingrato compito / quello di cercare / o forse è giocoforza registrare / che a me piace cercare / e non trovare”). C’è l’inquietudine filosofica (“Dubito quindi sono”), ma anche un’ironia sottile che spezza l’enfasi e rende l’opera sorprendentemente vitale. Zaniboni ama rovesciare l’ordine delle cose, proporre figure inattese, usare immagini dissonanti (“Le rondini nel cielo / ora sembrano croci vive / al cimitero”) che scavano un solco nell’immaginario del lettore. La scrittura è spesso ellittica, rapida, sincopata. I versi si inseguono come pensieri che cercano una forma, senza mai compiacersi del proprio suono. Ma a tratti esplodono in una musicalità inattesa, lieve, come nei ricordi d’infanzia o negli idilli naturali che affiorano in controluce (“A piedi nudi lungo il canale / pronti a seguire i salti delle rane”). È in questi momenti che si avverte un senso di grazia, un’estasi della memoria che non è semplice rimpianto ma tentativo di ricostruzione affettiva, di riconciliazione con la propria storia. Il rapporto con il tempo e con la morte è al centro dell’opera. Non una morte eroica, mitica, ma quotidiana, a volte banale, altre volte ferocemente ingiusta. Una morte che abita le strade, le case, le stanze dei solitari, gli sguardi dei migranti, gli occhi delle madri che perdono figli (“ho visto strappare dallo stelo, / piombare sull’asfalto / e avrei pianto / se non avesse fatto Ottocento”). La morte è l’ombra costante che spinge il poeta a interrogarsi, a sfidare il senso, a chiedersi fino all’ultimo se esista un senso (“Tù ya sabes qui l’ancora cala si resta / alla fonda mirando il faro”). Ma l’opera non è affatto priva di speranza. Al contrario: è proprio nella consapevolezza del limite che Zaniboni trova la spinta per continuare a scrivere, a rivolgersi agli altri, a lasciare “graffiti disperati” sulla “lavagna del giorno”. L’amore, la poesia, la fraternità, l’attenzione al dettaglio naturale, all’infanzia, agli affetti, a un “gesto semplice” d’amore: tutto questo diventa antidoto alla dissoluzione. In questo senso, la poesia stessa è un atto di fede laica, una resistenza simbolica alla deriva di un mondo che smarrisce i suoi valori fondamentali. Zaniboni appartiene a quella schiera di poeti che non cercano l’effetto, ma la verità. La sua scrittura, anche quando è colta e citazionale, resta fedele a un’urgenza autentica. Si sente che ogni verso nasce da un bisogno profondo, non da un esercizio di stile. E questo fa di “Fiori di creta” non solo una raccolta intensa e matura, ma una testimonianza esistenziale in cui il lettore può riconoscere il proprio affanno, la propria nostalgia, la propria voglia di bellezza. È, in definitiva, un libro che consola e inquieta, che accompagna e punge, che accarezza e denuncia. Come dovrebbe fare sempre, in fondo, la vera poesia.
Dalla finestra il formicaio bianco
e le vetrate su cui sorride il sole,
vincitore della nebbia
e il viale rosso di foglie
prima che i venti dell’ottobre
facciano scempio delle chiome.
Ride il cemento, pare non abbia
la faccia dello smog.
C’è qualcosa di umano
nel palazzone levato come mano
nel sereno
ed io lo guardo
e guardo le formiche lungo il viale,
perché altro non siamo,
visti dal dodicesimo piano.
E le formiche corrono imbizzarrite,
come ragni, a tessere sogni
fra l’oggi e il domani;
corrono a catturar chimere
nelle ragnatele della vita.
Dal mio studio in abito da clown,
guardo il formicaio che impazzisce.
Nelle vie a ciarlare, quando il sole si leva
e poi scompare,
di tutto a berciare per dimenticare la notte,
che scende a nascondere il mondo,
lasciando che si muoia giorno per giorno,
senza sfuggire ai lacci della sconfitta.
Sulle carte brucia lo slancio,
il canto intrigato dalla ruggine,
in lotta con la parola che da sola
non può dare poesia.
Sulle rive di un fosso, cerco il riflesso,
mi intenerisco al giallo del grano,
al papavero, sangue di un figlio perduto,
miro la prima stella.
Sussurro parole d’addio, mentre il gioco
si spegne del sole;
ricerco odori, segni di vita, ricordi,
la giovinezza fuggita e i tuoi occhi,
negli occhi dei fiori,
shakerando versi nel cocktail dell’illusione.
Dubito quindi sono.
A tergo dell’assioma
le cose andate male.
Ride l’anguria
mostrando il nesso
tra rosso e sesso.
Ridono le vetrate delle chiese,
cadenzando le preci di colori.
Risate dei martiri ai leoni,
dei leoni alle ossa
ormai spolpate,
delle ossa alle formiche
indemoniate...
E se fosse tutto
uno scherzo dei sensi
questo nostro arrancare
nel mare della notte
dove la vita fotte
ed è fottuta dalla morte?
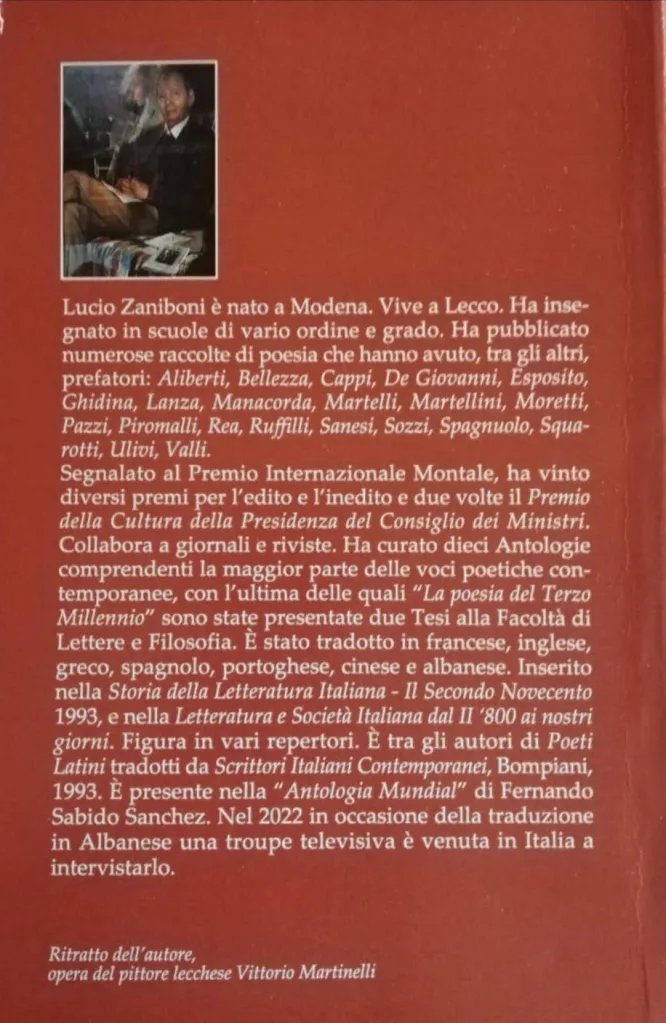
mi ha colpito soprattutto la prima poesia, a partire dal sorridere del sole che si specchia nelle risa del cemento. “ride il cemento”, in effetti, è un verso cardine: mi comunica sia che l’inumano è ormai più umano delle formichine stesse (e infatti, “C’è qualcosa di umano / nel palazzone”), sia che la menzogna c’è (mento), ovvero che la vita delle formiche imbizzarrite… non è vita. resiste e se la ride solo chi può permettersi di stare fermo: il vero duro… e infatti la durezza del cemento è proverbiale.
: )
quindi? un volo d’uccello dall’alto dello studio empireo (“dodicesimo piano”)?
direi di no, soprattutto grazie alla finezza nel finale dell’abito “da clown”, che chiude il gap di superiorità dell’io poetico rispetto agli schiavi operosi/operai. in sostanza l’io poetico è una Cassandra non solo condannata a non essere creduta/ascoltata, ma anche *derisa*.
non mi ha convinto, invece, il brusco salto di similitudine “formiche” a “ragni” (suona artefatto). con qualche verso in più magari era possibile giocare sulla crisi/perdita d’identità delle formiche, arrivando al fatto che nel frenetico mulinare di zampette non sembrano più sei ma otto o qualcosa del genere. oppure cassare del tutto i ragni e invece di tessere sogni le “brave” formichine potrebbero far provvista di *bisogni* indotti per l’inverno.
sto delirando? può essere, ma è soprattutto grazie alla potenza della prima lirica del lotto.
e seguitiamo a lottare, dunque! finché c’è parola c’è vita…
: )
e, inevitabilmente, grazie a Lucio Zaniboni e a Cipriano Gentilino per le loro. (parole).
"Mi piace""Mi piace"