
Mi sono imbattuto nell’opera di Danilo Dolci negli anni 70, quando mio fratello mi regalò il volume “Il limone lunare / Non sentite l’odore del fumo” edizione Laterza del 1972, allora frequentavo il circolo ARCI della Casa del Popolo di Cardano al Campo, e maturavo la mia idea di un comunismo che tenesse conto anche delle esperienze per così dire evangeliche, pensavo alla comunità di Nomadelfia, e alla riflessione di Aldo Capitini, del quale mi interessava in particolare l’esperimento di democrazia diretta con i COS (Centri di orientamento sociale), l’antifascismo e il riferimento a Gandhi.
Ma il mio modo di vedere le cose è completamente laico, e l’opera di Danilo Dolci mi sembrava possedesse questa caratteristica, la vedevo come un’attività politica, nel senso più nobile del termine, modulata da un percorso poetico.
Il libro di Abele Longo Danilo Dolci Environmental Education and Empowerment – Springer Edition, 2020, in modo ben documentato e con una scrittura chiara e comprensibile, mi ha consentito di ampliare quella mia primitiva prospettiva illustrando le tante altre sfaccettature del lavoro di Dolci, un precursore, quasi profetico nel saper fondere la pedagogia con l’ecologia, l’azione sociale con la critica ai processi produttivi, spesso irriguardosi verso l’ambiente e fonte di spreco.
Il fatto che sia scritto in inglese e che sia maturato in un ambiente universitario consentirà sicuramente una maggiore conoscenza e diffusione dell’opera di Dolci fuori dai confini italiani, anche perché le sue iniziative si inserivano già in modo naturale in quel movimento internazionale progressista che comprendeva Paulo Freire con La pedagogia degli oppressi (1968) , un autore che ho conosciuto per i riferimenti nel libro di Abele e che sto leggendo con grande interesse; Aldous Huxley, che nella nota di copertina di Poema Umano (ho la prima edizione Einaudi del 1974 autografata da Dolci) scriveva : “Danilo Dolci è uno di quei moderni francescani…..la fede e il rispetto fanno sì che egli continui costantemente a tentare di incoraggiare i deboli e gli sfortunati affinché diventino fiduciosi in se stessi ,di aiutarli ad aiutare se stessi”, poi Jean Piaget, Erich Fromm e Rudolf Steiner.
Il libro, molto ricco anche di apparati bibliografici, parte della biografia per arrivare agli strumenti di azione sociale e politica, come lo sciopero alla rovescia e quello della fame, e le marce per la pace, nonché la necessità della pianificazione organica, un modo per inserire nel processo maieutico lo stato in un dialogo continuo con la comunità. Tutta l’attività umana è concepita come un grande processo di educazione, dove tutti insegnano e tutti imparano creativamente.
La creatività in Dolci è strettamente collegata all’amore per gli altri, di conseguenza anche per tutto il mondo, tutto ciò che si ama si rispetta, e non si sfrutta. C’è l’unità intrinseca di tutte le creature che formano la vita.
Le sue osservazioni scaturiscono sempre dall’analisi puntuale di accadimenti concreti, come l’osservazione dei metodi inefficienti di pesca in Sicilia, documentati in Spreco (1960) e la conseguente necessità di rivedere le modalità di produzione per raggiungere l’armonia con l’ambiente.
Può quindi essere considerato un precursore dei concetti di Antropocene e di Capitalocene quando ci si riferisce all’era attuale dominata e plasmata come mai precedentemente dalla presenza umana, il secondo termine a me piace di più, perché mette in luce il fatto che l’ambiente viene devastato dai rapporti di produzione capitalistici, se la presenza dell’uomo nel mondo è invasiva è per via del modello capitalista che ormai regola i rapporti umani, ma il cui fine è solo quello di produrre ricchezza a tutti i costi, tutto il resto non conta.
Un interesse particolare per me ha il capitolo quarto, dedicato al nucleo centrale dell’attività di Dolci, alla sua intuizione principale, il metodo della Maieutica Reciproca (RMA Reciprocal Maieutic Approach), un approccio pedagogico che fonde l’attività di educatore con quella politica e di azione sociale in grado di incidere sul quotidiano.
Il termine Maieutica indica l’arte della levatrice, la capacità di far nascere un uomo, ed è mutuata da Socrate, che nei dialoghi platonici attraverso il continuo porre domande, guidava il suo interlocutore a scoprire dentro di se delle verità che non sapeva neppure di conoscere. Ma con una differenza fondamentale, l’attività socratica è monodirezionale, la parte attiva è riservata solo a Socrate. Nella maieutica reciproca, invece il dialogo è basato sulla parità di ruolo, è un dialogo adattivo che attraverso una risposta condivisa trasforma entrambi i dialoganti, è come se anche il bambino facesse nascere qualcosa nella levatrice.
Abele illustra come si svolgevano le sessioni di RMA, alle quali partecipavano gruppi di uomini e donne, che si interrogavano sui propri bisogni. Gli argomenti delle discussioni erano estremamente concreti, un esempio importante riguardò l’idea di una diga sul fiume Jato che raccogliesse le piogge invernali, che poteva rappresentare un importante miglioramento delle condizioni di vita, tanto più che la mafia prosperava anche vendendo l’acqua a prezzi maggiorati in queste zone da sempre aride.
Si affrontavano i problemi ponendosi domande essenziali:
Di cosa abbiamo bisogno?
Cosa possiamo modificare per far andare meglio le cose?
Quali sono i problemi che dovremo affrontare?
Si voleva che ciascuno esprimesse le proprie opinioni, perché per Dolci lo spreco è anche non apprezzare il contributo che ognuno è in grado di dare. Si passava poi all’analisi delle contraddizioni che emergono dal confronto delle diverse opinioni per raggiungere una soluzione condivisa e rispettosa delle differenze.
E’ un modo di risolvere i problemi superando l’individualismo attraverso una trasformazione personale che si ripercuote nella società civile, quindi nella nazione e a livello planetario. Si tratta quindi di mettere in comune la propria comprensione del mondo con la comprensione degli altri, perché la realtà è complessa e non può essere intuita e afferrata da una singola persona o da un numero ristretto di specialisti. Significa vincere la sensazione di sentirsi inadeguati, che poi non è altro che la paura di scoprirsi creativi dentro un processo che fluisce giorno dopo giorno, ma significa anche avere il coraggio di mettersi a nudo di fronte a tutti gli altri.
Il senso di questo processo è quello di incrementare il potenziamento del gruppo, a questo proposito Dolci introduce una importante distinzione lessicale distinguendo i termini “dominio” e “potere”, Il potere è un’analisi che porta ad un’autocoscienza del proprio stato di oppressione, ma anche della capacità di costituire un gruppo in grado di riconoscere i propri problemi, nel quale ogni individuo è in grado di dare il proprio contributo per uscire dalla passività modificando il proprio comportamento verso il mondo per una crescita collettiva, così si diventa più forti e “potenziati”.
Il dominio invece è una crescita propria ma a spese dell’altro, ottenuta attraverso la sua oppressione. Un accumulo di dominio porta ad un accumulo di schiavitù, così come nella visione marxista un accumulo di denaro porta ad un accumulo di povertà. Quello che si vuole è sostituire una società basata sul dominio con una basata sul potenziamento, per un mondo non basato sulla rivalità ma sull’armonia e sull’equità.
I risultati di queste riunioni sono riportate in Conversazioni contadine (1966) Mondadori , c’era anche un magnetofono per registrare le conversazioni, Franco Alasia ha trascritto i testi registrati.
Il metodo della Maieutica Reciproca confluì anche in un processo educativo per i bambini, viene aperto il ‘Centro Educativo Sperimentale di Mirto’, anche qui utilizzando i gruppi di discussione, ma anche i metodi pedagogici più avanzati di Steiner e Montessori, oltre ai già citati Capitini e Freire, il quale parteciperà attivamente al progetto, recandosi di persona nel 1976. Il punto fondamentale è quello di non imporre al bambino una verità caduta dall’alto, ma di prepararlo perché possa sviluppare e valorizzare tutte le sue possibilità da se stesso, imparare facendo esperienze, viene citata l’attività di disegno e di modellato come modo di esprimersi e di scoprire la realtà e la materia, così come la musica, non solo ascoltarla, ma comunque toccare gli strumenti, provare a eseguirla.
Il capitolo viene arricchito dall’esposizione di un esempio di utilizzo attuale di RMA in un contesto universitario, si tratta di un seminario al quale Abele ha partecipato nel 2018 organizzato dall’università di Palermo:
Emarginazione a due passi dalla Cattedrale, repressione e persistenza, una lettura ecocritica del Cortile Cascino di Palermo (Slums outside the Cathedral, Repression and Persistence, an Ecocritical Reading of Palermo’s Cortile Cascino’). A cura della Dr. Flavia Schiavo, docente di ‘Fondamenti di Urbanistica e Pianificazione Urbana’ (Dipartimento di Architetttura), e del Dr. Stefano Montes, docente di Antropologia Linguistica (Dipartimento di Cultura e Studi Sociali).
Cortile Cascino era un quartiere degradato di Palermo, in pieno centro, a pochi passi dalla cattedrale, che negli anni 60 ospitava un migliaio di persone che vivevano senza elettricità, senza acqua corrente e senza fognature. La situazione del quartiere viene descritta da Danilo Dolci nel libro: Inchiesta a Palermo (1956 Einaudi), dopo la pubblicazione del libro e lo sciopero della fame intrapreso da Dolci per protestare contro la situazione di degrado, Cortile Cascino venne sgomberato e demolito dalle autorità.
Abele cita anche dei documentari che mostrano con l’evidenza delle immagini la situazione disperata del quartiere:
Cortile Cascino (1962), Robert Young’
Children of Fate: Life and Death in a Sicilian Family, un documentario focalizzato su una famiglia di Cortile Cascino trent’anni dopo (1992) realizzato dal figlio di Robert Young, Andrew Young.
Viva Palermo e Santa Rosalia (2005) di Daniele Ciprì and Franco Maresco.
Di seguito i link del materiale che ho trovato, un documentario della RAI, Children of Fate diviso in sei parti, e i documentari di Ciprì e Maresco:
Cortile Cascino Palermo 1962/1992 (Documentario) – YouTube
Cortile Cascino II – Children Of Fate (Ita sub Eng) part 1 of 6 – YouTube
Cortile Cascino II – Children Of Fate (Ita sub Eng) part 2 of 6 – YouTube
Cortile Cascino II – Children Of Fate (Ita sub Eng) part 3 of 6 – YouTube
Cortile Cascino II – Children Of Fate (Ita sub Eng) part 4 of 6 – YouTube
Cortile Cascino II – Children Of Fate (Ita sub Eng) part 5 of 6 – YouTube
Cortile Cascino II – Children Of Fate (Ita sub Eng) part 6 of 6 – YouTube
Ciprì e Maresco – Cortile Cascino 1961 – Robert Young. – YouTube
Ciprì e Maresco – Viva Palermo e Santa Rosalia – YouTube
Il metodo RMA viene spiegato agli studenti, seduti in circolo che per prima cosa presentano se stessi attraverso i propri progetti di vita e le proprie aspirazioni. Poi comincia la discussione focalizzata su come preservare la memoria del Cortile Cascino, di seguito riporto solo alcune delle riflessioni e suggestioni:
– Gli studenti notano che parecchie persone anche se di Palermo ignorano l’esistenza di Cortile Cascino.
– Su questo tema non solo le istituzioni ma anche i cittadini devono avere un ruolo chiave.
– Le idee devono nascere dal basso, non dall’alto delle istituzioni.
– Lo spazio potrebbe essere convertito in un’area verde.
– Si potrebbe attivare un bando per studenti universitari allo scopo di avere ulteriori nuove idee, etc….
La seconda parte del seminario è focalizzata sulla produzione di un piano d’azione condiviso risultante dalla discussione di tutti i punti presentati dagli studenti:
- Contattare il centro Danilo Dolci per lo sviluppo creativo e altre associazioni di volontariato.
- Coinvolgere il comune con una lettera aperta e i cittadini della zona per ascoltare idee su come dare sviluppo all’area
- Raccogliere testimonianze e immagini per una pubblicazione.
- Iniziativa di adozione dell’area da parte dei cittadini.
Il riscontro da parte degli studenti è stato positivo, l’hanno considerata un’esperienza unica e di grande interesse, si sono sentiti impegnati e motivati a produrre un loro contributo utile per la città.
Un altro capitolo particolarmente interessante riguarda la poesia come strumento di azione e pratica ecocritica. Abele paragona la poetica di Dolci con quella di Walt Whitman, “Leaves of grass”, l’umanità come un insieme di foglie d’erba, ogni singola foglia è debole, ma l’intera prateria è forte, compatta e immortale, perché in armonia con le altre foglie e con la natura.
Poesia come inizio dell’educazione, ogni foglia si riconosce parte dell’universo. Poesia è una modalità corale, che lascia a ciascuno la sua voce. Poesia è sviluppare una relazione maieutica, con la poesia non si va verso il popolo, si è popolo. Poesia è meditazione sulle cose e anche sull’invisibile che le circonda.
Whitman come Dolci operava un lavoro infinito sulla sua poesia, rivedendone e correggendone continuamente i versi, ma è proprio quello che succede quando si agisce nella vita quotidiana, si rivede sempre quello che si è fatto e si riaggiusta tutto all’infinito. Entrambi i poeti condividono poi una modalità recitativa, così come nelle discussioni serve la parola che esprima esattamente la realtà, nella poesia è la stessa ricerca maniacale della parola esatta, la sola che, gettata nel mondo, può accendere le relazioni con il prossimo e quindi con tutte le creature viventi.
In conclusione Abele si chiede cosa è rimasto dell’opera di Danilo Dolci. Dopo la sua morte le sue idee sono state per un lungo periodo pressoché dimenticate, sembra invece risorgere negli ultimi anni un interesse, in particolare per la sua attività pedagogica, ci sono due associazioni a Palermo che promuovono a livello internazionale con progetti educativi il suo pensiero:
Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci. https://danilodolci.org/.
Guidato da Amico, figlio di Danilo Dolci .
CESIE centro studi e iniziative europeo https://cesie.org/.
Mi piace concludere citando l’ultima bellissima frase del libro di Freire, che si adatta bene anche all’opera di Danilo Dolci:
Se nulla resterà di queste pagine speriamo che resti almeno la nostra fiducia nel popolo. La nostra fede negli uomini e nella creazione di un mondo dove sia meno difficile amare.
E’ bello che il libro sia da Abele “Dolcemente” dedicato alla moglie Joc.
Giancarlo Locarno
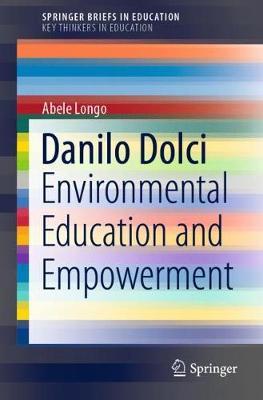
Un grazie immenso, Giancarlo. Una poesia da “Il limone lunare” per esprimerti la mia gratitudine e riportarti agli anni in cui frequentavi l’ARCI della Casa del Popolo di Cardano al Campo;
Tralucere di olive sulle onde
continue di frumento,
indefinito brillare di acque,
giallo sbandare di una farfalla,
invisibile origano,
viti a filari coi tralci più chiari in cerca di sole
tra biancheggianti tronchi di platani
ancora lucidi di alba
mentre la strada si inoltra verso l’opaco giorno,
figure, volti passano come inesistenti
presenze staccate
(certe penetrano e altre vanno
labili via:
quali restano e quali se ne vanno?)
mentre nell’intimo premono a fiotti
e s’intrecciano urgenze che non sai –
i vuoti si allargano
e il rischio che i frammenti, senza senso
rimangano frammenti.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Questo libro sulla vita esemplare di Danilo Dolci e scritto con la devozione e la passione che Abele sa immettere in ogni suo lavoro, si configura come un libro necessario. La sua necessità è tanto più urgente oggi, in questo tempo di continue fratture, egoismo, costruzione di muri, mancanza di solidarietà. Ma già, grazie ad Abele, questo esempio di altissima etica in gesti e parole sta viaggiando, attraversa i meridiani, metterà radici ovunque, getterà semi per la solidarietà globale. Per costruire un’umanità diversa, che allontani la spinta assurda all’autodistruzione.
"Mi piace""Mi piace"
“Tutta l’attività umana è concepita come un grande processo di educazione, dove tutti insegnano e tutti imparano creativamente.” ecco un concetto fondamentale, come pure basilare è il concetto della maieutica *reciproca*, che molto sarebbe d’aiuto per scardinare il mio nanoforisma preferito (l’incomunicabilità muove il mondo). in proposito, non posso che tornare a sottolineare che il concetto di maieutica reciproca condensa in due parole quello “stranissimo” fenomeno mentale che spesso mi piace citare in base al quale se io ti comunico un pensiero e tu mi comunichi un pensiero restiamo con due pensieri a testa, mentre se io ti do un pugno, un bacio, un euro, un panino e, nel contempo, tu mi dai un pugno, un bacio, un euro, un panino restiamo con un solo pugno/bacio/euro/panino a testa.
il bisogno di sapere (interrogarsi/capire/esperire) è il punto di partenza, ma resta prettamente egocentrato (come il Poeta) e sterile (da un punto di vista comunicativo/sociale) se non s’interfaccia a “flusso biunivoco” (reciproco) con la volontà di ascoltare gli altri sia in “viva voce” (dialogo), che in “differita” (leggere/studiare). purtroppo la disponibilità all’ascolto – non so cosa ne pensi tu, ma ahimè, più passano le decadi e più lo noto – è ormai ridotta al lumicino nell’homo sapiens tecnologicus in piena deriva individualistica/narcisistica/tweetteristica e ciò spiega perché i “poeti” ormai si contino sulla punta delle dita mentre i “Poeti” siano sempre lì.
ciò mina alla base anche (e soprattutto) le colonne portanti della maieutica reciproca e le mie aspettative sul futuro prossimo venturo dell’umanità.
eh, a proposito: sono d’accordo con te, “capitalocene” è molto più centrato.
: )
grazie come sempre per l’impegno di lettura/elaborazione ma soprattutto di condivisione su Neobar dei tuoi pensieri. e grazie e complimenti e un abbraccio forte anche ad Abele sia per l’opera pubblicata su Danilo Dolci che per l’esistenza stessa del sito.
"Mi piace""Mi piace"